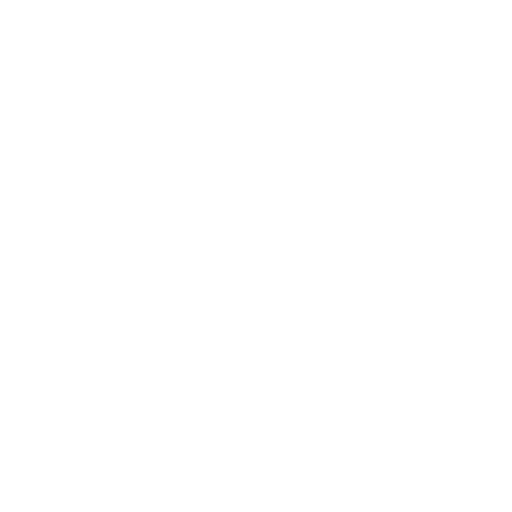Sara ha un lavoro gratificante, un marito e due figlie. La sua vita agli occhi del mondo è perfetta. Suo marito è un facoltoso imprenditore che assicura alla famiglia ogni genere di lusso e sicurezza.
Ma Sara vive all’inferno perché ogni giorno subisce prevaricazioni, vessazioni e umiliazioni.
Dopo anni in cui era diventata l’ombra di sé stessa, Sara, ha faticosamente trovato il coraggio di separarsi e, maturata la consapevolezza di ciò che ha silenziosamente subito, vorrebbe chiedere il risarcimento di tutti i danni, di tutto il dolore che lei ma anche le sue figlie hanno provato.
Ma dove stanno questi danni, le chiede il suo avvocato, anticipando la domanda di un giudice.
Sara ha ottenuto ciò che voleva e nel frattempo, con una forza ed una determinazione ai limiti dell’ostinazione, è riuscita ad avere la vita che voleva: ha fatto carriera ottenendo numerose promozioni, ha tanti amici, viaggia e può permettersi ciò che desidera.
Quindi, le viene detto, i danni che ha subito forse non sono poi così seri perché altrimenti avrebbe perso il lavoro, non vorrebbe frequentare le persone, avrebbe avuto un tracollo psico fisico.
Sara è solo un nome, che rappresenta tanti uomini e donne che nel rapporto di coppia subiscono violenze psicologiche subdole, non visibili, che non lasciano i segni come un pugno, ma sono altrettanto devastanti; anzi, forse peggiori perché un pugno ti consente quantomeno di andare al pronto soccorso, dai carabinieri; i segni sul corpo si possono fotografare e sono universalmente riconosciuti come violenza.
Queste violenze subdole e reiterate uccidono o rafforzano, ma non lasciando tracce visibili in modo oggettivo, non sono risarcibili.
Il caso di Sara rispecchia una frequente realtà giudiziaria italiana: avere risorse che ti consentono di sopravvivere e di farcela equivale a non vedersi riconosciuto il danno effettivamente sofferto. Inoltre, se la vittima è un uomo, oggigiorno, dovrà scontrarsi con una giurisprudenza ricca di “pregiudizi”.
A quella che si può sommariamente etichettare come violenza psicologica fanno capo una moltitudine di condotte apparentemente irrilevanti, ma che reiterate nella quotidianità minano la forza interiore, la volontà e la vitalità di un essere umano.
All’interno della vita coniugale, ci sono persone apparentemente perfette: lavorano, sostengono in misura rilevante o esclusiva tutte le spese per il menage familiare, sono socievoli e di gradevole presenza.
Eppure il loro atteggiamento è perennemente volto a screditare, umiliare ed annullare la compagna o il compagno. Queste persone non picchiano, non urlano, ma sono parimenti feroci, violente e sadiche. A volte si “limitano” a negare sistematicamente fatti che invece sono realmente accaduti al fine di far dubitare l’altra/l’altro della propria memoria o farla/o addirittura sembrare letteralmente pazza/o.
Tale forma di violenza prende il nome di gaslighting, o manipolazione psicologica maligna.
Certamente il nostro sistema giudiziario riconosce anche i danni psicologici, ma solo quando questi si manifestano in modo concreto e tangibile.
Il vero paradosso di questi casi sta nel fatto che più la vittima è capace di reagire e di “tirarsi fuori” da una situazione velenosa e pericolosa e più difficilmente ha possibilità di vedersi riconosciuto il giusto risarcimento per il danno che ha subito, magari per anni.
Alcune condotte meriterebbero di essere giudicate attraverso l’applicazione dei cosiddetti “punitive damages” del sistema giuridico statunitense.
Si tratta di un istituto giuridico attraverso il quale i giudici, o meglio le giurie, sono in grado di commisurare il risarcimento non parametrandolo al solo danno biologico della vittima, ma anche attraverso un’automatica punizione del colpevole. In tal modo la vittima oltre ad essere riconosciuta come tale, spesso viene risarcita in misura molto superiore rispetto all’entità del danno che è in grado di provare.